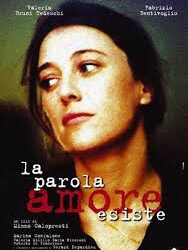Incontro con Gianni Canova sul film “La parola amore esiste” di Mimmo Calopresti
Senatore: Gianni, ti ringrazio di essere intervenuto al Convegno (VII Congresso SOPSI N.d.R). Prima di proiettare il film “La parola amore esiste”vuoi dire qualcosa agli psichiatri che sono in sala?
Canova: Io mi occupo di cose molto più frivole di quelle che tramano i vostri interessi professionali quotidiani. Non so bene perché sono qui ma, forse, mi piace essere qui, perché non so bene il motivo per cui ci sono. Una delle cose che amo particolarmente del cinema me le ha rivelata uno dei cineasti che amo di più, Alfred Hitchcook, il quale diceva che il cinema ha tra l’altro questo di bello che assomiglia alla vita con una differenza; é meno noioso e non ha i tempi morti della vita. Questo é forse uno dei motivi per cui qualche legittimità mia ad essere qui c’è. E cioè che in un film stesso, si può trovare condensato e concentrato ciò che nella vita ha bisogno di più tempo, i tempi morti per estrinsecarsi. Nel cinema, a volte, possiamo vedere rappresentati, in maniera estremamente sintetica e suggestiva, temi, problemi, sintomi, relazioni tra significanti e significati che, appunto, possono aiutarci, ad illuminare meglio gli stessi problemi e gli stessi temi nella realtà. Il film che stiamo per vedere o per rivedere, ha a che fare, credo, con questo. A prima vista, ha che fare con il rapporto fra le parole e le cose, con il rapporto che le lega, con la crepa che le separa e divide ma, quindi, poi con il rapporto tra i significanti e i significati, tra i sintomi e i vissuti a cui essi rinviano. In fondo, a me piace leggerlo come un film che lavora sui progetti di connessione e deconnessione del rapporto tra significanti e significati. Già il titolo é emblematico: “La parola amore esiste”: esiste un significante, che rinvia ad un certo vissuto e non é detto che nella storia che stiamo per vedere esista un vissuto che, in qualche modo si connetta a quel significante. Il cinema mi ha insegnato personalmente su questo tema, sui processi di connessione e di deconnessione. C’é un film che amo molto e che mi piace ricordare ed é appunto un film su questo. E’ un film interpretato da un grasso e da un magro, Stanlio e Ollio… Ed in un film verso la fine degli Anni Trenta, credo del 39, il film che si chiama nell’edizione italiana “Noi siamo le colonne” ci mostra i due, il grasso e il magro che si perdono in un labirinto davanti all’Università. Mi pare di ricordare che fosse Oxford. E i due si dividono, vanno uno da una parte, uno dall’altra per cercare un segno che indichi l’uscita dal labirinto. Ad un certo punto uno dei due, mi pare di ricordare il magro, vede piantata una manina di cartone, un segno iconico che indica la direzione dell’uscita. Primo piano sul viso esultante del magro che si avvicina alla manina di cartone, la strappa da terra e torna indietro nel labirinto a cercare il grasso per dirgli: “Ho trovato”. Ecco un esempio metaforicamente suggestivo di deconnessione tra i significanti e i significati che é un problema con cui ha a che fare la protagonista del film che stiamo per vedere, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi. Una protagonista che si circonda di segni anche quando a questi segni non corrisponde un senso. Immerge la sua vita in una grammatica ed in una sintassi di significanti scaramantici, profilattici che è fatta di colori, di numeri per cui il bianco va bene, il nero no, il rosa dipende, il tre è un buon numero, il due no, neanche l’undici perché l’undici è uno più uno- due e quindi, quando incontra un uomo che ha un maglione rosso, che abita al numero tre e che, in qualche modo, rientra nel sistema di significanti deconnessi dai significati, decide di innamorarsi di lui,vuole innamorarsi di lui. Non vi dico altro sul film, se non una brevissima osservazione di ordine più teorico- metodologico. C’é una figura di un terapeuta su cui non diamo giudizi per ora che è interpretato dal regista. Il regista ha deciso di fare anche l’attore e di attribuire a se, non a caso, il ruolo del terapeuta. In un ‘intervista Mimmo Calopresti ha detto:” In fondo il regista é un po’ il terapeuta di un film…Il cinema e la psichiatria hanno molti punti in comune…”. Io non so se questo sia vero o no. Vi invito di osservare, con particolare attenzione, il finale di questo film, perché so che voi, nel vostro lavoro quotidiano, date molta importanza al nesso tra verbale e non verbale… Noi che ci occupiamo di cinema, ragioniamo spesso sul nesso tra visibile e sul non visibile e spesso é ciò che al cinema non si vede è che dà senso, spesso, a ciò che si é visto. E’ un finale singolarmente simile ad un finale di un film americano “Qualcosa é cambiato” con Jack Nicholson. Jack NIcholson, in quel film aveva delle fobie e delle ossessioni molto simili a quelle della protagonista del film; per esempio non voleva mai calpestare con i piedi le strisce pedonali ….(che, è una della fobie che ha anche Angela, la protagonista di questo film). Ebbene, nel finale di “Qualcosa é cambiato”, il personaggio NIcholson sta guarendo, attraversa la strada e il regista di quel film, si sente quasi in dovere di fare un dettaglio ravvicinato sul piede di Nicholson che calpesta la striscia bianca, quasi a dirci: “Attenzione é guarito”. Fate attenzione a come chiude Mimmo Calopresti questo film. Lei e lui, l’uomo che ha aveva deciso di amare si ritrovano, l’auto resta senza benzina ed i due la spingono e ci sono delle strisce bianche, delle strisce pedonali in lontananza. Non c’è nessun dettaglio sul piede dei personaggi, anzi si allontanano verso il campo lungo, verso un qualcosa che resta confinato nel non visibile, delegando, quindi, allo spettatore, il compito, se lo vuole e se lo ritiene di ipotizzare un senso a quell’incontro e all’esito che avrà, oltre la fine della storia. Il senso é ancora una volta é nel non visibile e siamo noi spettatori chiamati, in qualche modo a ricostruirlo. Forse i veri terapeuti del film, ma più in generale del cinema, non sono gli attori che interpretano terapeuti ma siamo sempre noi spettatori.
Senatore: Dopo la proiezione del film, posso dire anch’io qualcosa. Proiettare questo film era una sfida importante….In questo film ci sono tutti gli ingredienti c’è lo psicoanalista, c’é la paziente che ha un disturbo fobico-ossessivo…Come sai, uno dei titoli che avevo scelto per il mio ultimo volume era “La sindrome di Sheherazade”, perché credo che noi terapeuti, come la protagonista del primo racconto de “Le Mille e una notte”, per non morire, dobbiamo raccontare storie ai nostri pazienti…Un altro dei titoli possibili era “Per una poetica dello sguardo”. Riprendendo il tuo invito a rivedere l’ultima scena del film, ci hai “insegnato” a vedere questo film con un’ottica completamente diversa…La scommessa, Il mio sforzo, anche all’interno della Società, é quello di aiutare lo psichiatra a vedere un film, i nostri pazienti, con uno “sguardo” diverso e non a porsi domande del tipo: “Ma la protagonista é veramente una paziente ossessiva-compulsiva? “L”intervento dello psicoterapeuta é stato corretto?”…
Canova: Una delle cose che a me sembrano interessanti di questo film é la costruzione di una semeiotica del disagio nel personaggio interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, perché il rischio di farne un personaggio macchietta, un personaggio stereotipato, un personaggio deja vù era molto forte e lavorando su segni minimi, su una semeiotica e una prossemica molto minimalista ma molto precisa l’attrice e il regista sono riusciti, da questo capo chino, quel modo di mettere le mai spesso congiunte in grembo… e sopratutto dalla deriva dello sguardo del personaggio. Mi veniva di pensare, se questo film trasmette sottopelle un lievissimo disagio allo spettatore, questo deriva sopratutto dal fatto che, quasi tutti i personaggi hanno degli sguardi che non sono mai precisamente direzionati, non capisci mai bene dove stanno guardando. In Valeria Bruni Tedeschi questo è evidentissimo, salvo nella parte finale, su cui tornerò tra pochissimi secondi…Il suo sguardo non é mai diretto sull’interlocutore; è uno sguardo sempre leggermente di sbieco, sempre leggermente scostato rispetto a dove ti aspetteresti… Anche il personaggio di Bentivoglio ha uno sguardo, così, sempre leggermente deviato rispetto ad una presunta norma. Un’altra cosa che notavo è che, mi sembra che il regista non faccia quasi mai uso, salvo un caso clamoroso, di quel procedimento tecnico che, in genere, i registi usano quando vogliono fare scattare meccanismi di immedesimazione tra lo spettatore e il personaggio che è il meccanismo della soggettiva (cioè collocare la macchina da presa nel punto esatto dello sguardo del personaggio, in modo da illudere lo spettatore di vedere con gli occhi del personaggio) é il meccanismo da Hitchcook in poi)… Calopresti non le usa, volutamente, quasi per “raffreddare” il film. C’è solo una soggettiva clamorosa nel finale ed è il momento apicale del film ed é quando Bentivoglio, finalmente, guarda negli occhi lei, ma attraverso lo specchietto retrovisore dell’automobile. Mi sembra che sia l’unico caso fortemente così connotato di incroci di sguardi ed in quel punto, con la mediazione dello specchio, si carichi di un valore simbolico molto forte.
Senatore: Vorrei aggiungere due cose…Anche l’ultimo film di Calopresti rimanda ad un titolo “rubato”…”Preferisco il rumore del mare” é un verso di DinoCampana...Ritornando al finale, Bentivoglio é al telefono e non si sa con chi sta parlando…ed é solo allora che dichiara ad alta voce la sua passione per Angela…la parola amore esiste ma nessuno dei personaggi può dirlo ad alta voce alla persona che ama…
Canova: E’ verissimo, infatti, l’amore di lei é dichiarata da Marina Confalone e non da Angela…
Senatore: Puoi regalarci una tuo ultimo commento?
Canova: Un’ultima considerazione preliminare, mi colpiva, come tutti i personaggi siano dei personaggi incapaci di produrre segni o pratiche comunicazionali, tutti rubano segni altrui. Il titolo è rubato dal regista da un verso di Margherite Duras, come rubati sono i biglietti di Angela, come rubate sono le parole della canzone di Pino Daniele…Non è solo Angela che dice: “Ho quasi trent’anni e non faccio niente, non mi sono laureata”, ma il violoncellista é così poco sicuro della propria identità di musicista che ha il timore di suonare in pubblico, il terapeuta si dichiara a sua volta confuso e respinge i pazienti. E’ tutto un universo di identità che non si compiono totalmente che lascia un certo disagio nello spettatore…
Gianni Canova, critico cinematografico, insegna Storia e Critica del cinema presso la Libera Università di Lingue e ComunicazioniI IULM di Milano. Dirige il mensile “Duel”. E’ autore dei volumi “David Cronenberg”- Il Castoro(1994) e “L’alieno e il pipistrello” – Bompiani (2000).
Roma 22.2.2002